la veste, il cappuccio e
la buffa della compagnia. A Parma pagò il chierico perchè si lasciasse
mettere in testa l'elmo e brandisse la spada di Alessandro Farnese, giù
nella cripta al chiarore delle torcie. A Ferrara, entrando nella celletta di
Sant'Anna, mi accorsi ch'egli tremava di commozione, e pallido lo vidi
uscire dal carcere ove fu chiuso il povero amante di Parisina. E intanto
preveniva nuove emozioni desiderando, sognando Venezia e i quadri
del suo Tintoretto, sul quale aveva due anni prima scritto il suo
prediletto dramma.
Non so dire se più dell'arte egli amasse la libera natura, Fin da fanciullo
ebbe sotto gli occhi i malinconici dintorni del suo Limbiate e i grandi
boschi di pino silvestre che coprono una vasta zona dell'alto Milanese,
luoghi di caccia una volta e di sontuose villeggiature, oggi
ingiustamente abbandonate. Per quei boschi, nati nell'ingrato solco
della sodaglia, i sentieri si avviluppano in un inestricabile labirinto di
selve, fra eserciti agglomerati di conifere, sottili, diritte, vicine, che
quasi si toccano, che tolgono la luce del cielo o la lasciano solamente
biancheggiare fra ciuffo e ciuffo pallidamente. E scendono e salgono le
viottole in un mare di eriche e di felci. Stride la gazza, passa a volo, e
va squassando le ali a posarsi sull'orlo d'un laghettone, in cui la piova
del bosco si riversa in uno stagno viscido e giallastro che dorme nel
silenzio verde della pineta. Tu vai e vai per miglia e per ore e non trovi
che solchi, avvallamenti e nuovi eserciti di pini scaglionati su una vetta,
talchè ora ti pare d'essere a un valico alpino, ora in un parco reale, ora
in un deserto. Non una voce odi, non un fiato, se non è quello del vento
che passa al disopra: o tutto a un tratto lo scoppio aspro d'un fucile e il
frascare d'un cane. Vai ancora. Il bosco si schiarisce.
Al di là scorgi un non so che di bianco. È un cimitero abbandonato,
sepolto nel verde, dove vorresti sdraiarti tutto supino, colle mani in
croce, e chiudere gli occhi, e dormire, dormire nel seno molle della
madre terra.
Fra questi boschi era solito errare il giovinetto colla mente accesa dai
tanti romanzi storici che noi tutti in quegli anni abbiamo avidamente
cercati. E il bosco a lui pareva d'un subito che si popolasse di cavalieri
erranti, armati di ferro, di donzelle bionde e di tutti i più bei fantasmi
che uscivano soltanto al tocco degli antichi liuti.
I boschi non soffrono d'anacronismo e a chi le chiama bene vengono
incontro anche le vergini amadriadi.
Il romanticismo vinceva negli anni che corrispondono alla giovinezza
d'Ambrogio Bazzero le sue ultime battaglie, accompagnando il
frastuono delle battaglie vere per la patria. Tutti abbiamo avuto, qual
più qual meno, qualche castello nel cuore e una spada di Toledo nel
pugno. I più giovani, i più timidi erano i più leggieri alle
immaginazioni. Il Bazzero, d'ingegno facile, senza le noiose distrazioni
del bisogno, con un'anima semplice, con tanto medioevo appiccato alle
pareti del suo studio, potè meglio di molti altri ricreare quel mondo
morto intorno a sè. Nè lo ricreava per sola vaghezza d'antiquario, come
si disse, ma perchè gli pareva che in quel mondo astratto i suoi sottili
ideali respirassero meglio che nell'aria grossa della realtà pregna di
cose. Da questo raccoglimento uscì il suo Buondelmonte, l'Angelica
Montanini e l'Ugo, in cui la conoscenza dei tempi e dei costumi è così
ricca e precisa e i rapporti così studiati nella lontananza dei tempi, che
il lettore moderno, sorpreso dal gran numero delle evocazioni rimane
confuso, e accusa d'oscurità e di confusione un'arte che ha il difetto di
essere troppo minuziosamente precisa.
Ma chi ha tanta pazienza di rileggere e d'aspettare che l'impressione si
snodi trova cento luoghi d'ammirare e finisce col sentire in sè la forza e
l'anima dei tempi. Nell'Ugo specialmente, romanzo che stancò lo stesso
autore, l'impressione finale è propriamente quella di sentirsi sotto il
peso cupo del più cupo secolo della nostra storia, il decimo.
Chi più di tutti sentiva il fascino di queste risurrezioni era l'autore,
quando si svegliava dalla sua meditazione con tutte le prove vive e
parlanti intorno a sè dell'opera sua.--Chi può capire la potenza di certe
mie pagine?--scriveva nel libro dell'Anima, in un sincero abbandono
con sè stesso; non fa meraviglia, quindi, che al vedere gli amici suoi
impassibili o indifferenti, il pubblico non curante, la critica scempia e
ingiusta, provasse tanto dispetto da buttar via la penna, da chiudere i
libri negli scaffali, da maledire le sue armi, le sue notti perdute. Erano i
mesi dello sconforto: poi ritornava da capo, e avrebbe vinta la partita,
son certo, se la morte non avesse voluto vincere prima di lui.
* * *
Di questi scritti che non fanno parte del presente volume,
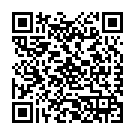
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



