et aggionti alla provvigion del dinaro
nell'agosto del 1745 si videro obbligati a porre un freno alla disastrosa ed infruttuosa
corrività della Repubblica verso la nobiltà dalmata; corrività che minacciava, di rovinare
le «camere (_tesorerie_) di quelle province, costringendo per questo oggetto a farsi più
abbondanti et frequenti le missioni di pubblico danaro per le esigenze di quelle parti»
[11].
Nè più valeva a risollevare l'intisichito spirito di ventura tra i Dalmati--i mercenari per
eccellenza--l'imagine della forza e della potenza guerriera della Serenissima. Le parvenze
esterne dell'imperio, alle quali si affidava buona parte del suo prestigio presso le
popolazioni soggette, erano precipitate a quel tempo in uno stato di abbandono colpevole.
«Le fortificazioni di Levante, della Dalmazia e dell'Albania--scriveva nel 1782 il
brigadiere degli ingegneri Moser de Filseck al Doge--sono in uno stato di desolazione
tale da commuovere a riguardarle... A Zara, ogni parte delle opere componenti i recinti e
le fortificazioni è in rovina... Spàlato è in decadimento, ed un nemico può eseguirvi un
colpo di mano, a suo talento... Lo stato infine del forte S. Francesco a Cerigo fa
rabbrividire pel decoro del Principato»[12].
Le armi vecchie e rugginose avevano dunque disamorato i venturieri a detergerle in Italia,
ed Oltremare. Restava soltanto qua e là per la Dalmazia ed in Levante qualche guizzo del
fulgore antico, raccomandato ad un sentimento di gratitudine giammai sopito nel cuore
delle genti d'altra riva dell'Adriatico verso la Veneta Repubblica, che le aveva raccolte
sotto le proprie ali nei tempi più travagliati della Cristianità e difesi contro il Turco. Ed a
questi sentimenti, le ultime compagnie di ventura italiane avevano raccomandato i loro
estremi giorni di vita a Venezia.
* * *
L'altra fonte delle milizie venete era rappresentata dalle _cerne _, che fornivano soldati
dei luoghi ordinati con previdenze territoriali, specie di Landwehr che si levava in tempo
di guerra o di neutralità a rincalzo dei mercenari, cioè dei provvisionati. Le cerne venete,
o soldati d'ordinanza, emanavano adunque direttamente dal pensiero politico e militare di
Nicolò Macchiavelli, che volle l'istituto delle milizie nazionali tratto dal popolo
pedestremente armato[13].
Costituiva il nerbo delle cerne l'elemento rurale dei domini di Terraferma e d'Oltremare,
cui la Serenissima aveva fatto larghe concessioni per rinfrancarlo nel suo innato spirito
conservatore ed adescarlo a servire, lietamente ed in buon numero, nella milizia regionale.
Di queste prime pratiche conservò memoria il Bembo.
«Deliberò il Senato--egli scrisse--che, nel Veronese, l'anno 1507, un certo numero di
contadini che potessero armi portare, si scegliesse e descrivesse; i quali all'arte militare si
avvezzassero, e costoro liberi da tutte gravezze fossero, acciò più pronti alle cose della
guerra essere potessero, e chiamati alle loro insegne incontanente v'andassero. Il qual
raccoglimento di soldati di contado agli altri fini della Repubblica (come suole l'uso
essere di tutte le cose maestro) in breve passò e si diffuse. Il perchè ora le ville ed i
ragunamenti degli uomini del contado di ogni città, parte de' suoi hanno che a questa cosa
intendono, di essere armati ed apparecchiati di maniera che, senza spazio, alla guerra
subitamente gire e trovarsi e servire alla Repubblica e per lei adoperare si possono. E
queste genti tutte soldati di ordinanza, o cernite, si chiamarono»[14].
La guerra della lega di Cambrai, combattuta per l'integrità dei domini della Signoria,
consolidò questa milizia paesana e la fece popolare, ad onta dei tentativi fatti per
denigrarla--più che tutto dopo lo sbaraglio di Vailate--per opera dei troppo interessati
fautori delle milizie assoldate, gli industriali della guerra d'allora. In sostanza, si voleva
rovesciare sopra i soldati di ordinanza un po' di quel discredito e di quella noncuranza di
cui gli eserciti regolari furono sempre prodighi verso le «guardie nazionali».
Il grande vantaggio delle cerne consisteva, anzitutto, nel loro costo sensibilmente minore
in confronto del necessario per mantenere un eguale numero di soldati di mestiere.
Toccava infatti al comune di descriverle, di armarle e d'inquadrarle in centurie; laddove
questo còmpito, per i soldati di mestiere, toccava ai capi-leva che ne ritraevano un utile
per sè e per la compagnia. Anche i gradi delle cerne, fino a quello dei capi di cento
incluso, si attribuivano di massima per elezione nei villaggi che contavano il maggior
numero di descritti.
Gli obblighi di questi ultimi erano limitati a cinque mostre o rassegne annuali
(_mostrini_), oltre a talune riviste straordinarie (_generali_) in luoghi designati, con il
comune consenso dei soldati medesimi, escluse però le fortezze, le terre murate, i castelli
ed i grossi villaggi. Epperciò le rassegne si compievano d'ordinario in rasa campagna.
Le cerne dovevano presentarsi alle rassegne con le armi che avevano personalmente in
consegna dai comuni, come si pratica per lunga tradizione nella Svizzera: le assenze
erano punite con la descrizione a galeotto, oppure con la multa di 5 ducati[15]. In queste
rassegne le cerne ricevevano la polvere da moschetto, il piombo
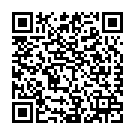
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



