F. NANI MOCENICO--_Giacomo Nani--Memorie e documenti_--Venezia, Tip.
dell'Ancora, 1893:
V. MARCHESI.--Tunisi e la Repubblica di Venezia.--Torino, Roux edit.
A. MENEGHELLI.--Vita di Angelo Emo.--Padova, 1836.
M. FERRO.--Dizionario del Diritto comune e Veneto.--Venezia, Santini Edit. 1845.
S. ROMANIN.--_Storia documentata di Venezia_--Vol. IX, Venezia, 1850.
8. ROMANIN.--Lezioni di storia veneta.--Firenze, Le Monnier, 1876.
P. MOLMENTI.--_Storia di Venezia nella vita privata_--Parte Terza--Il
decadimento.--Bergamo, Istituto Italiano di Arti Grafiche, 1908,
CASONI.--Forze militari (in Venezia e le sue lagune, Vol I).
A. RIGHI.--_Il conte di Lilla e l'emigrazione francese a Verona_. (1794-1796)--Perugia,
Bertelli edit., 1909.
E. PESENTI.--Angelo Emo e la Marina Veneta del suo tempo.--Venezia. Naratovich,
1899.
LA CAMPAGNA DEL 1796 NEL VENETO
PARTE PRIMA
LA DECADENZA MILITARE DELLA SERENISSIMA [Blank page]
CAPO I.
Le fonti della milizia veneta.
La sera del 2 giugno 1796 deve essere stata assai tragica per i senatori veneziani
convenuti al casino del procuratore Pesaro, alla Canonica[3], per deliberare intorno a
gravi oggetti concernenti la Repubblica. Il provveditore generale in Terra Ferma, Nicolò
Foscarini, aveva avuto il dì avanti, sotto Peschiera, un colloquio burrascoso con il
generale Buonaparte, nè gli era riuscito a rabbonirlo che a prezzo di dolorose abdicazioni
per la dignità della vetusta Serenissima. E l'uomo nuovo, con la visione dinanzi agli occhi
di sconfinati orizzonti di gloria, si era trovato di fronte all'uomo del passato, che vedeva
chiudersi per la sua patria quegli orizzonti medesimi sotto il velo grigio e melanconico
del tramonto.
Il generale Buonaparte aveva accusato il Senato Veneto di tradimento per avere permesso
giorni avanti agli Austriaci di occupare Peschiera, di slealtà per avere dato asilo in
Verona al conte di Lilla, di parzialità colpevole--come egli diceva--per male
corrispondere alle pressanti esigenze di vettovaglie e di carriaggi da parte dell'esercito
francese, di neutralità violata infine in vantaggio dei nemici suoi, gli Austriaci.
Ora, di tutto questo, Buonaparte aveva dichiarato al vecchio Foscarini di doverne trarre
aspra vendetta per ordine del Direttorio, incendiando Verona e marciando contro Venezia.
Il rappresentante Veneto, atterrito, era riuscito alla fine a indurre il focoso generale a più
umani consigli ed a salvare Verona, ma più con l'aspetto della sua desolata canizie che
con la virtù della parola, a condizione però «che le truppe «del generale Massona fossero
ammesse in città, occupassero «i tre ponti sull'Adige, avvertendo che le minime
rimostranze «che si imaginassero di fare i veneti riuscirebbero il segnale
«dell'attacco[4]».
Tra l'incendio e l'occupazione militare non era dubbia la scelta, ed al Foscarini fu
giocoforza di cedere. Duramente Buonaparte aveva rifiutato al vecchio provveditore
perfino il tempo necessario, per prendere gli ordini dal Senato e lo aveva accomiatato
«con i modi che il vincitore detta leggi al vinto[5]».
Era il principio della fine della Serenissima. All'udire i dolenti messaggi del Foscarini,
l'accolta dei senatori veneti alla Canonica, pavida, discorde, sfiaccolata, non trovò altro
rimedio al male che spacciare due Savi del Collegio a Verona per assistere il provveditore
in altri colloqui con il generale Buonaparte, quasi che il loro mandato fosse quello di
sorreggere con le dande gli estremi passi del valetudinario diplomatico e della
agonizzante Repubblica.
La fiducia nelle arti della parola e del protocollo rappresentava ancora, agli occhi dei
contemporanei, l'ultima àncora di salvezza, perchè i tempi di Sebastiano Verniero e di
Francesco Morosini erano trascorsi da un pezzo. Ed i due nuovi eletti in quella
tumultuaria adunanza notturna per implorare mercè al vincitore di Dego, di Millesimo e
del ponte di Lodi, furono Francesco Battagia e Nicolò Erizzo I. Essi partirono sùbito alla
volta del campo francese sotto Verona, recando seco «40 risme di carta di buona qualità,
12 risme di carta piccola da lettere lattesina, 2000 penne, 3000 bolini grandi ed altrettanti
piccioli, 36 libbre di cera Spagna, un barilotto di inchiostro, 6000 fogli di carta imperiale,
registri, spaghi e spaghetti in grande quantità».[6] La burocrazia aulica della Serenissima,
in difetto di soldati e di armi, così provvedeva alla difesa delle sue città murate e del suo
territorio.
A quel tempo, l'esercito veneto si era oramai consunto per vecchiezza. I lunghi e sfibranti
periodi di pace e di neutralità in cui l'inazione suonava colpa e l'assenteismo politico della
Repubblica, prolungata offesa alla dignità del vecchio e glorioso Stato italico,
l'abbandono, lo scadimento d'ogni istituto, lo scetticismo e l'indifferenza, avevano
siffattamente prostrata la milizia veneziana da imprimere sul suo volto, un tempo già
gagliardo e raggiante per le vittorie d'Italia e d'Oriente, le rughe più squallide della
decrepitezza ed il marchio più profondo della dissoluzione.
La bella e radiosa visione del monumento a Bartolomeo Colleoni, fiera ed energica come
il suggello di una volontà prepotente, stupenda come l'annunzio di una vittoria pressochè
astratta dall'ordine dei tempi, grado a grado si era dileguata nell'esercito della Serenissima,
come svanisce un sogno carezzato alla luce di una triste realtà. * * *
Il nerbo degli armati della Serenissima traeva
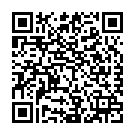
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



